Month: December 2017

Posted in Media features
Dans Jacobin Magazine (16 déc. 2017)
Dans le magazine socialiste américain Jacobin, Miranda Hall décrit l’impact des plateformes de micro-travail au Moyen Orient. En discutant les… read more Dans Jacobin Magazine (16 déc. 2017)
admin 17 December 2017
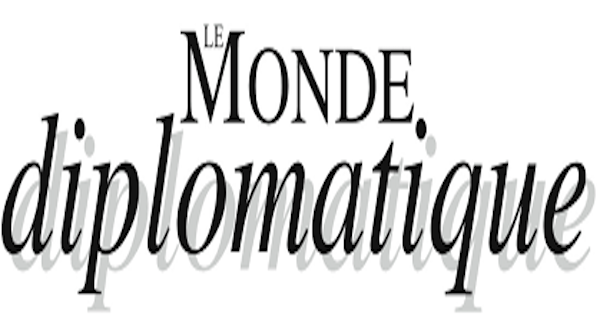
Posted in Media features
Dans le Monde Diplomatique (déc. 2017)
Dans Le Monde Diplomatique (plus précisément dans son bimestriel « Manière de voir »), Thibault Henneton se penche sur la… read more Dans le Monde Diplomatique (déc. 2017)
admin 9 December 2017

Posted in Media features
“I lavoratori sono il cuore dell’algoritmo” : intervista ne Il Manifesto (Italia, 9 dicembre 2017)
[NB: This interview has been translated in English, Spanish, and Portuguese] Nel quotidiano Il Manifesto di sabato 9 dicembre 2017,… read more “I lavoratori sono il cuore dell’algoritmo” : intervista ne Il Manifesto (Italia, 9 dicembre 2017)
admin 9 December 2017